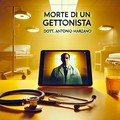Paura e periferie: tornare a pensare la città in città
La nuova rubrica di PoliSofia
Nell'era del digitale e dello smart sembra di passare da una concezione della storia lineare ad una storia fatta di sbalzi, di modulazioni, di crescite repentine, tanto da creare confusione. E un sintomo o una opportunità di questi sbalzi del progresso sono conservati proprio nelle città. Il continuo affluire di persone nelle città, con culture, tradizioni, usi, visioni della vita e del mondo sempre più differenti e disparate, provoca una richiesta allarmante di identità e, soprattutto, di identità forti per cui ogni individuo sarebbe pronto ad abdicare alla propria libertà in cambio di una sicurezza sempre maggiore nelle sue cose da fare, in cosa pensare, nella opinione da poter dare o, meglio, sbandierare.
L'ultimo esempio di questa difficile convivenza politica l'abbiamo vista con il Congresso delle Famiglie di Verona, tenutosi a marzo scorso. Congresso che ha visto una ulteriore alzata di scudi e di proteste da parte di tutti i movimenti Lgbt e di difesa dei diritti civili. Insomma, l'identità forte rinforza le altre identità creando società sempre più chiuse, barricate in alcune zone della città. Infatti, il problema non si risolve solo con l'aderenza ad un partito politico o ad una identità sociale, ma si complica maggiormente nella misura in cui le città iniziano a diventare terreno di convivenza comune. Dove la convivenza assume sta assumendo soluzioni sempre più restrittive. In altre parole, nelle città iniziano a crearsi società chiuse, dove ognuno può sentirsi a proprio agio solo con quelli della propria cultura, che condividono lo stesso pensiero, che fanno le loro scelte economiche. Proprio sul piano economico, ancor prima che etnico, si possono constatare le maggiori chiusure all'interno della città. Ci riferiamo, in particolar modo, al fenomeno delle banlieues e gated communities. In un suo ultimo articolo comparso sulla rivista Logoi.ph, Lucivero descrive questo duplice fenomeno che stanno attraversando/subendo le città.
Scrive Lucivero:
Al contrario, le grandi città dei nostri giorni, dal punto di vista urbanistico, hanno assunto dappertutto la stessa conformazione: accanto a un nucleo più o meno antico, non sempre presente e non sempre di interesse storico rilevante, si è sviluppata successivamente una zona economica fatta di grattacieli, la cosiddetta city, centro del potere economico, e ai margini della città si sono sviluppate due zone grigie, le banlieues e le gated communities, che qui vogliamo analizzare per i risvolti sociali a cui rimandano, per la loro funzione di ostacolo ai processi di inclusione sociale, quelli dominati dall'idea di "solidarietà", di cooperazione, di integrazione delle competenze e dall'idea di comunità: si tratta di aree in cui agiscono forze centrifughe di senso opposto rispetto all'idea stessa di città, due luoghi chiusi in cui le paure si moltiplicano, anzi questi luoghi sussistono proprio in ragione di un sentimento diffuso di paura, e in cui i "desideri" di vita in comune, di prossimità, rimangono perlopiù simulati, apparentemente esauditi, ma per mezzo di succedanei temporanei, a patto di grandi perdite sociali e umane.
Nel suo saggio Lucivero prosegue descrivendo le banlieues come periferie per poveri, dove il tasso di socialità, pur essendo alto, rimanda anche a fenomeni di criminalità diffusa, di organizzazione criminale dovute alla scarsa cultura, alla mancanza di lavoro e di prospettive future. Le banlieues sono le periferie come le conosciamo noi, quelle che Pasolini descriveva quando parlava delle borgate romane, che ritroviamo anche nella nostra città, caratterizzati più per essere quartieri dormitorio che spazi di socialità. Le gated communites, invece, sono spazi di periferia per ricchi. Alla lettera, infatti, gated communities può essere tradotto con comunità-cancello dove gente facoltosa può permettersi di vivere in spazi lussuosi, in quartieri attrezzati, puliti, sicuri, dove l'ingresso è riservato solo a gente con un alto tenore di vita. Per questo motivo, dunque, sono comunità chiuse, che lasciano spazio solo ad una identificazione economica e professionale, che tagliano fuori gran parte dell'umanità. Insomma, sono piccole isole felici, dentro un mondo in fiamme.
In entrambi i casi parliamo di periferie ma in una prospettiva differente da quella della comunità poiché siamo nell'utilizzo economico del suolo. In altre parole, la città non è più il centro della società, dove i ruoli, pur nel reciproco riconoscimento, venivano rispettati e riconosciuti. Oggi la città, soprattutto le grandi metropoli, diventano lo specchio delle disuguaglianze provocate dal capitalismo globale, da una economia del consumo che frammenta e spezza i legami sociali. Ma se, in entrambe queste periferie, ciò che davvero governa è la paura, diventa sempre più necessario e urgente un ritorno al pensiero, un ritorno ad una pratica comunitaria innestata sul coraggio di pensare. Per il semplice fatto che, pensando viene meno la paura. E questo vale per ogni essere umano, dalla Preistoria all'Oggi.





.jpg)

.jpg)
 Ricevi aggiornamenti e contenuti da Bisceglie
Ricevi aggiornamenti e contenuti da Bisceglie 
.jpg)

.jpg)
(1).jpg)
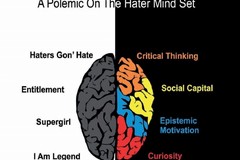


.jpg)
.jpg)